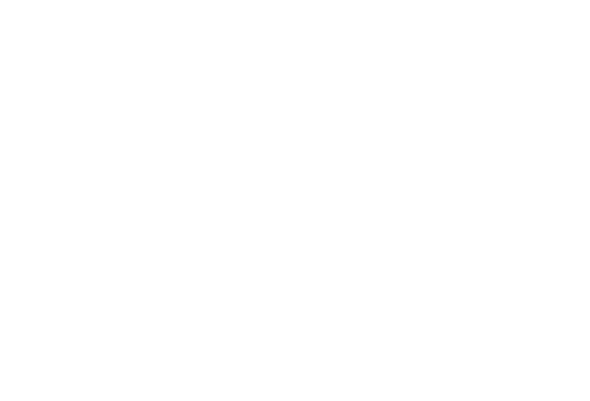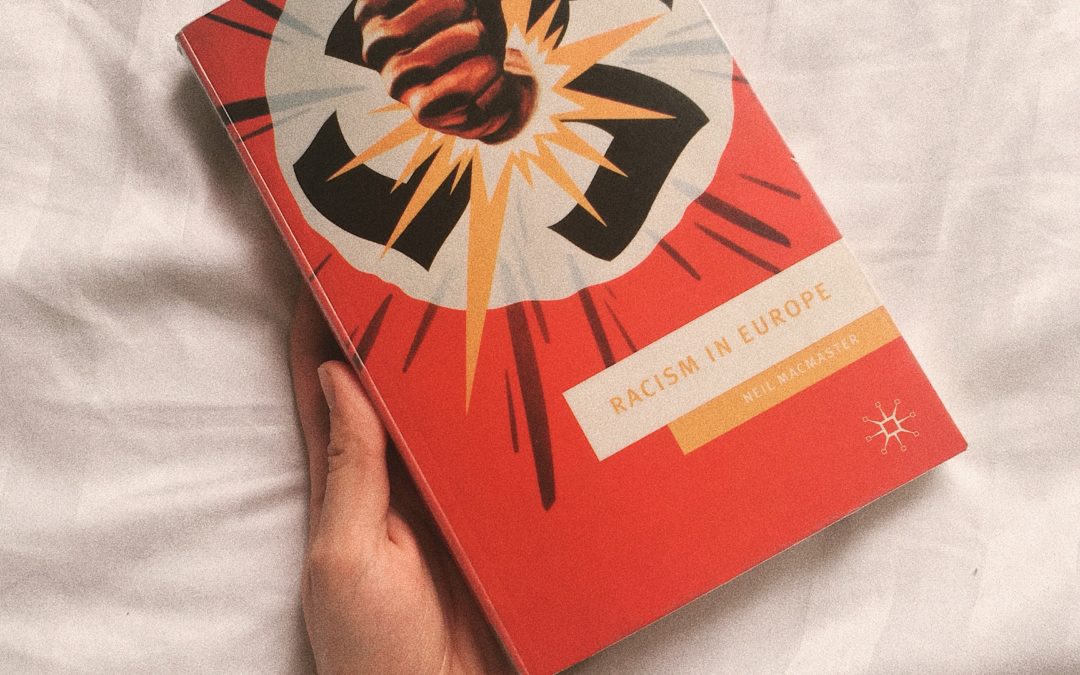da Giorgia | 26 Giu 2020 | Zero Waste
Per una volta, scelgo di empatizzare con voi amanti dell’estate – che, guarda caso, siete anche quelli che abitano al mare e hanno zero peli sul corpo marmoreo (scusate, niente risentimento). Per una volta, chiudo entrambi gli occhi e pubblico un post dedicato all’estate e ai suoi costumi da bagno – o swimwear, se vogliamo fare gli anglosassoni – interamente sostenibili.
I problemi di inquinamento dell’industria tessile ormai non sono più (si spera) una novità alle orecchie dell’opinione pubblica. Lo sappiamo, i processi di produzione di questo settore comportano un eccessivo consumo di acqua e impiego di sostanze chimiche, che spesso vengono deliberatamente disperse nell’ambiente. Parliamo di costi sociali ed ambientali talmente alti da aver reso la moda il secondo settore più inquinante al mondo. Un bel problemone per noi Occidente consumista fino al midollo!
E’ tempo di rivoluzione, per la Terra e per i lavoratori. Abbiamo bisogno di una rivalutazione dei processi produttivi; di una maggiore attenzione alle condizioni di lavoro del personale e alle materie prime impiegate. Non si può pensare di poter vendere in Italia, delocalizzando la produzione in Bangladesh o Etiopia per abbassarne i costi. Non si può più acquistare un costume a 15€, senza sapere chi lo ha cucito e a quale prezzo.
Eccovi quindi una lista di brand di swimwear – dai, facciamo gli anglosassoni per benino – davvero attenti all’ambiente e ai lavoratori. Ho scelto marchi prevalentemente italiani, con fabbriche e stabilimenti in Italia o Europa, dove i controlli sulla qualità del lavoro sono notoriamente più frequenti. No brand di capi disegnati a Parigi, per poi essere prodotti in Cina, per intenderci.
CasaGIN – Made in Italy: abiti, intimo e costumi da mare realizzati consapevolmente, in armonia con il ritmo lento della natura. I tessuti impiegati nella produzione sono in fibre vegetali biodegradabili, prodotti a partire da materie prime rinnovabili. Eucalipto, legno di faggio, plastiche rigenerate e cotone organico si mescolano per creare la loro linea estiva.
Nello specifico, i costumi sono in ECONYL (al 78%); si tratta di un materiale a base di un filo di nylon rigenerato, recuperato dagli scarti di reti da pesca o boe. (qui il loro sito)
Balajanas – Made in Italy: altro brand totalmente italiano – sardo, per la precisione – che utilizza il filo di nylon rigenerato ECONYL. Questo tessuto ecologico è in grado di assicurare un alto grado di vestibilità, resistendo anche ad abrasioni, salsedine e creme solari. (qui il sito)
SOSEATY: Il progetto è di una start up veneta, che ha fatto dell’economia circolare il suo punto di forza. I pantaloncini da uomo sono realizzati in poliestere riciclato (SEAQUAL), recuperato attraverso la pulizia degli oceani e la trasformazione della plastica delle bottiglie. Nella linea donna, invece, ritroviamo il buon vecchio ECONYL menzionato prima, questa volta con nylon rigenerato al 65%.
Tutti i materiali impiegati provengono da siti non più lontani di 300 km dal centro di produzione, in modo tale da minimizzare – quanto possibile – le emissioni di CO2 in termini di trasporto. (qui il loro sito)
Repainted – Italian Beachwear: una moda locale, artigianale con capi realizzati a partire da filato ECONYL, resistente a raggi UV, cloro e solari. Dal design particolare e ricercato, rappresenta un piccolo investimento destinato a durare molto più che una collezione o una sola estate. Chiaramente tutto italiano, dai materiali agli stabilimenti produttivi. (qui trovate la collezione 2020)
AllSisters: brand che produce responsabilmente in Spagna, utilizzando materiali eco, certificati italiani. Realizza bikini e pezzi unici dal taglio timeless e chic – modo ricercato per dire “ne prenderei due pure io, grazie!”. Secondo il sito di rating tessile Good On You, non è chiaro se garantisca o meno un minimo salariale, ma trattandosi di una produzione spagnola possiamo (quasi) starne certi. (Qui per maggiori info)

da Giorgia | 21 Giu 2020 | Slow Eating
Sentiamo – giustamente – tanto parlare di caporalato, di frutta e verdura italiana in mano alle agromafie. Ci sentiamo colpevoli di aver finanziato per decenni questo violento e pericoloso sfruttamento umano, e ora vogliamo agire.
Dove e cosa comprare, allora, per smettere di contribuire alla morte dei braccianti che lavorano per mettere il cibo sulle nostre tavole?
POMODORO ROSSO SANGUE
La filiera etica inizia il suo cammino dai campi di pomodoro dal Tavoliere delle Puglie. È proprio in questa regione che si coltiva il 40% della produzione nazionale di questo ortaggio, diventato simbolo dello sfruttamento dei braccianti agricoli e simbolo della ribellione contro questo sistema alimentare iniquo.
L’associazione fondata da Yvan Sagnet – sindacalista e attivista camerunese per i braccianti – è la prima rete internazionale che si occupa di tracciabilità e trasparenza delle etichette. È proprio nel Foggiano che nasce la prima certificazione anti-caporalato (NOCAP), che mira a contrastare le pratiche sporche e garantire ai produttori il prezzo giusto.
È proprio il prezzo della commercializzazione a rappresentare il problema. La Grande Distribuzione Organizzata strozza continuamente i prezzi di vendita dei prodotti alimentari, con pratiche scorrette come le aste a doppio ribasso, generando ripercussioni violente su tutta la catena produttiva. (Lo spiego meglio qui)
IAMME: marchio di passata di pomodoro, pelati, salsa di datterino, salsa di ciliegino e salsa di datterino giallo. Acquistabili online o nei supermercati Megamark del sud Italia.
SFRUTTAZERO: passata di pomodoro ideata dall’associazione Diritti a Sud, che prevede l’impiego di lavoratori locali o stranieri impiegati con contratti regolari nei campi di Nardò, Puglia.
FUNKY TOMATO: azienda di filiera partecipata. Il consumatore diventa ingranaggio attivo, attore nella stessa produzione della passata di pomodoro, acquistando preventivamente le passate di pomodoro. In questo modo finanzierà la produzione e i regolari contratti dei lavoratori.
GOOD LAND: progetto dell’associazione No Cap, con un modello produttivo che include la sostenibilità ambientale. La qualità del prodotto non è solo etica, poiché i campi seguono il metodo di produzione biologica. (Qui per sapere come acquistare)
TOMATO REVOLUTION: marchio di passate di pomodoro di Altromercato, che si affida ad aziende agricole libere da mafie e sfruttamento del lavoro nero. Sul sito trovate tutte le informazioni sul metodo di produzione bio e sulle aziende coinvolte nella filiera. Tracciabilità totale! (Qui per l’acquisto)
SPESA E ALTRI PRODOTTI
Al momento la certificazione “caporalato free” è limitata alla produzione di pochi prodotti, soprattutto nel sud Italia. In attesa che questa si sviluppi e raggiunga anche i supermercati e mercati del resto dello Stivale, possiamo fare affidamento su i piccoli produttori del nostro territorio. Sostenere il piccolo anziché sempre e comunque la Grande Distribuzione Organizzata è un passo importante. Ciò permette di fare rete, creando una comunità di persone, e non solo di consumatori.
Le alternative tra cui scegliere sono tante: mercati coperti, aziende agricole locali, vendita diretta. Potreste provare con i GAS – gruppi di acquisto solidale – che nascono dall’esigenza di una filiera corta e pulita. A Torino ce ne sono almeno 80, con cui acquistare prodotti etici, sostenibili e davvero a km0. Il funzionamento è semplicissimo: fate la spesa online e poi passate a ritirala nel vostro GAS più vicino.
Altrimenti ci sono i mercati dei Produttori Agricoli di Campagna Amica, luoghi in cui trovarvi difronte a chi ha coltivato e prodotto quel cibo che state acquistando. Vengono organizzati settimanalmente, in diversi luoghi della vostra regione. Consultate il sito per trovare quello più vicino a voi.
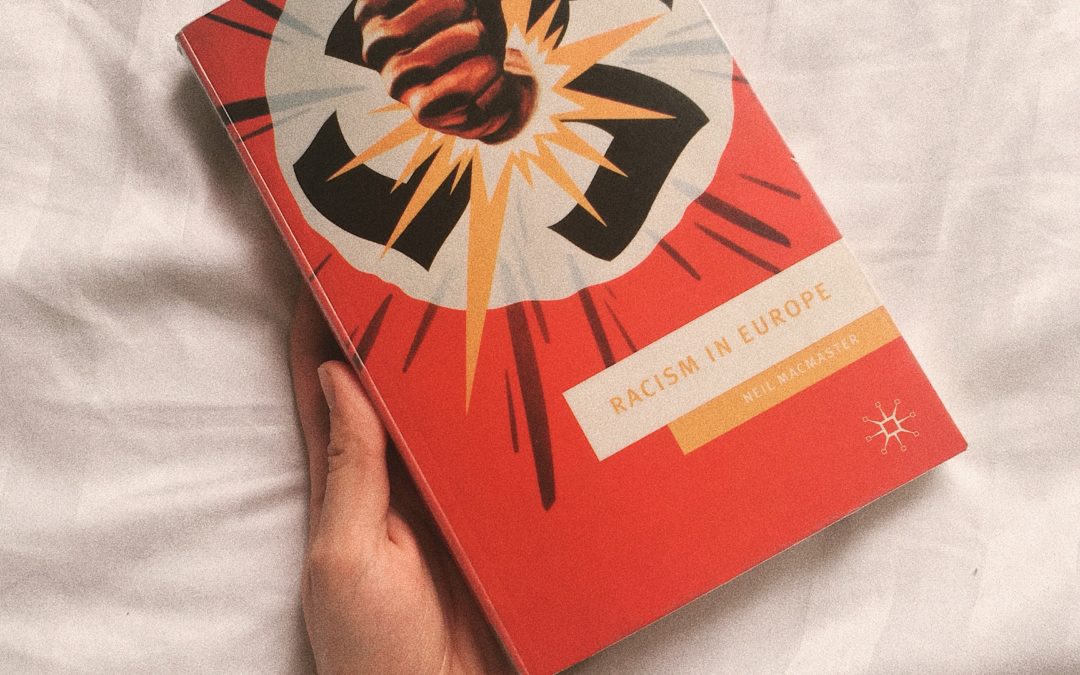
da Giorgia | 13 Giu 2020 | Informarsi
La morte violenta di George Floyd, per mano della polizia statunitense, ha innescato una bomba nell’America di Trump. Movimenti di protesta si sono diffusi a macchia d’olio prima negli USA, per poi attraversare l’Oceano, arrivando con forza dirompente in Europa e resto del mondo. Stiamo ormai assistendo alle manifestazioni di protesta più partecipate degli ultimi 50 anni.
Così il Black Lives Matter è arrivato anche in Italia, dove il fenomeno sociale del razzismo è ben radicato. Non parliamo solo di atti violenti nei confronti delle minoranze, ma della diffusione di pensieri e ideologie xenofobe, che si fondano indebitamente sull’idea di “razze superiori e inferiori” e che riguardano la quotidianità.
Tuttavia, il razzismo italiano ha radici storiche e sociali ben diverse da quello americano. E dovremmo approfittare di questo momento per allargare la discussione, rendendola più inclusiva.
Questo vuol dire che in quanto bianchi abbiamo il dovere di riflettere sul sistema sociale in cui viviamo, riconoscendo il privilegio sistemico istituzionalmente riconosciuto sulla base del colore della nostra pelle. Perché è solo riconoscendo questo privilegio che si potranno instaurare alleanze in grado di combattere sistemi di ingiustizia e violenza strutturale.
Le manifestazioni di protesta devono essere un momento di alleanza di corpi, di unione di voci. Se è vero che in Italia, il razzismo è perpetuato nei confronti dei non-bianchi, non è escludendo i bianchi dal movimento di riconoscimento dei diritti umani che risolveremo la questione razziale.
Il sistema razzista è stato creato dai bianchi per i bianchi. È stato creato a nostro beneficio, garantendoci per secoli ampie fette di ricchezza e diritti. È quindi nostro dovere morale esaminarci la coscienza, le mani sporche di sangue, e mettere fine a questo sistema iniquo. Non dobbiamo e non possiamo sentirci esclusi dal movimento per il riconoscimento dei diritti degli oppressi, perché quel problema razziale lo abbiamo causato NOI.
È doveroso, oggi, ascoltare le testimonianze di chi vive sulla propria pelle questo tipo di discriminazione quotidiana, ma è anche necessario che chi ha goduto e stragoduto dell’ingiustizia, ora, sia chiamato in causa; non per essere sottoposto al linciaggio mediatico o politico, ma per sottoporsi ad una riflessione sul suo privilegio.
Altrimenti finiamo per ghettizzare il movimento per l’antirazzismo, limitandolo ad un bianchi vs neri, quando in realtà è un fenomeno assai più complesso e diversificato, che varia a seconda del contesto di riferimento.

da Giorgia | 6 Giu 2020 | Slow Eating
Mai come quando si avvicina l’estate sentiamo parlare di caporalato. In questi giorni, con un certo anticipo sulla stagione estiva e con un accento sulla questione regolarizzazione, il fenomeno del caporalato è tornato ad occupare la scena mediatica. Tuttavia, pochi conoscono davvero il nuovo schiavismo che le etichette alimentari non trasparenti portano con sé.
Ma come funziona il caporalato?
La Capitanata, distretto per eccellenza del cosiddetto “oro rosso”, vede il radunarsi di decine di migliaia di braccianti di pomodori. Si tratta di una transumanza di corpi, di raccoglitori stranieri stagionali, che si spostano per guadagnarsi da vivere. I turni massacranti li vedono costretti a 12-13 ore di lavoro al giorno sotto il sole cocente tipico dell’estate pugliese. Piegati sui campi per rifornire la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) della materia prima necessaria per le passate di pomodoro, simbolo del tanto osannato Made In Italy.
Il lavoro è sfiancante. La paga misera. Le condizioni abitative raccapriccianti. I lavoratori, impiegati illegalmente, senza un contratto o garanzie, conducono un’esistenza tra pareti di lamiera delle baracche e distese di campi da coltivare. Parliamo di nuovi ghetti, posti ai margini della società. Abitazioni di fortuna ed insediamenti informali, senza acqua corrente, elettricità, con letti squallidi e latrine senza un vero impianto fognario.
La presenza di questa popolazione rappresenta una ghiotta occasione di business per le agromafie; personale sprovvisto di documenti da poter sfruttare a piacimento nella raccolta di pomodori, ma anche di asparagi, uva, broccoli. Pagati a cottimo, sulla base della velocità: 3,50€ per un cassettone di pomodori. A fondamenta del lavoro non ci sono contratti, ma accordi informali gestiti dei “caporali”.
Sono loro gli intermediari; spesso della stessa nazionalità dei lavoratori, i caporali reclutano i braccianti da impiegare a giornata. Regolano il lavoro, costituendosi come anello di congiunzione tra produttore e braccianti. Organizzano tutto (anche i servizi accessori, come il trasferimento dai ghetti ai campi, il compenso, il posto letto) e sottraggono percentuali dalle paghe dei malcapitati.
Stabiliscono loro chi lavora e chi no. Chi si ribella, o chiede giusti compensi, muore.
Il caporale però è solo uno degli elementi a costituzione della catena di sfruttamento della manodopera agricola in Italia. Un anello paramafioso, ma non strettamente all’origine dell’orrore subito dai braccianti.
Il problema infatti sta a monte. O forse, meglio, a valle. I pomodori raccolti finiscono sugli scaffali della GDO. Al supermercato, la passata di pomodoro, grazie ad una costante azione di strozzamento dei prezzi, finisce nelle mani dei consumatori per soli 0,39€. Un gioco malato di prezzi, costantemente a ribasso, che si ripercuote però sull’anello più debole della catena alimentare: i braccianti. La GDO comprime i costi, limitando il margine di guadagno del produttore, che è a sua volta costretto a tagliare i propri costi, pagando una miseria i lavoratori. Basta allargare un po’ lo sguardo e l’orizzonte appare già più nitido. Il prezzo più alto è pagato da chi raccoglie, non da chi acquista.
Il grande paradosso della filiera agroalimentare italiana, tutt’altro che sana.
L’attuale governo ha perso una grande occasione, posticipando ulteriormente la caduta di questa filiera sporca. La regolarizzazione del nuovo “decreto rilancio” è temporanea (permesso di soggiorno garantito dai 3 ai 6 mesi).
Per combattere il caporalato ci vogliono documenti in regola per chi lavora; un’azione politica a beneficio di tutto il comparto produttivo. Necessaria è poi unatrasparenza della filiera, dal campo alla tavola. Le etichette devono certamente raccontare il marchio, ma anche la materia prima che rappresentano. La certificazione biologica non basta più se c’è chi muore per una scatola di pelati.
NO CAP
C’è un caldo afoso a Douala, ma Yvan non stacca nemmeno per un secondo lo sguardo dal televisore. Maldini sta per calciare, momento che tiene il bambino con il fiato sospeso. L’Italia si sta giocando il suo Mondiale, e con esso anche il futuro della sua agricoltura. Sarà lo stesso Yvan a stravolgerne le sorti, qualche anno più tardi. Innamoratosi con quelle immagini calcistiche del Bel Paese e del costume italiano, decide di imparare la lingua e fare domanda per una borsa di studio. La otterrà nel 2008, approdando nei trafficati corridoi del Politecnico di Torino, per studiare ingegneria delle telecomunicazioni. Per mantenersi gli studi, si trasferisce più a Sud, in cerca di un lavoretto estivo.
Arriva tra i campi di pomodoro di Nardò, Puglia, nell’estate del 2011. Ed è qui che la sua vita cambierà per sempre.
Yvan scopre il caporalato. Lo sfruttamento dei braccianti agricoli. L’iniquità delle paghe. Le lotte per garantirsi un letto su cui passare la notte. Resiste, tiene duro per qualche tempo. La goccia che fa traboccare il vaso dell’esasperazione di Yvan è larichiesta di intensificare il lavoro sotto il sole cocente. Le 16 ore non bastavano più al suo caporale. Così il ragazzo si organizza con i suoi compagni di sventure. Mettono su il loro primo sciopero autonomo, facendo leva sulla dialettica e maggiore consapevolezza di come gira il mondo di Yvan. Un momento di svolta per chi non conosce alcun riconoscimento normativo.
La sete di libertà e giustizia fa risuonare in tutta Europa le condizioni di lavoro disumane di chi produce il cibo con cui imbandiamo le nostre tavole. Per la prima volta, il caporalato diventa reato in Italia.
Qualche anno più tardi, Yvan Sagnet pubblica due testi – tra cui figura anche la sua autobiografia – e viene insignito della nomina di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per mano e volere di Mattarella.
Con l’associazione No Cap, di cui è presidente e fondatore, Yvan ora cerca di diffondere la cultura dei diritti (quelli brutalmente calpestati dei suoi precedenti datori di lavoro). “No Cap” ad oggi è diventato anche il bollino di garanzia dell’assenza di sfruttamento tra i campi di pomodoro. Così vengono bollate scatole di pelati e bottiglie di passata. La volontà è quella di una produzione sostenibile, che rispetti terra e collaboratori. Garantire un’etichetta trasparente e narrante, in difesa dei braccianti e a garanzia dei contratti.
UNA BUONA ETICHETTA
Il caporalato ci riguarda tutti. Ci coinvolge e ci trasforma in mostri e carnefici, nella nostra oziosa quotidianità. Il cibo che mettiamo sulle nostre tavole si macchia del sangue di chi muore di fatica nei campi.
Quei “prezzi sempre bassi” del supermercato dietro casa sono all’origine del problema. Dietro quelle offerte irrinunciabili, c’è lo strozzamento di un’intera filiera alimentare. C’è la violenza dei caporali e lo sfruttamento dei braccianti irregolari. C’è la nascita di ghetti senza elettricità e lotte tra disperati. Quando acquistiamo un marchio piuttosto che un altro, stiamo scegliendo quali dinamiche produttive finanziare e sostenere.
Il consumatore ha quindi il diritto e l’obbligo di sapere cosa sta acquistando. La necessità di una certificazione di assenza di caporalato – come quella “no cap” – dovrebbe essere la regola, soprattutto quando si parla di vite umane. Acquistare una passata di pomodori marchio Eurospin a 0,39€ significa giocare alla roulette russa; chi morirà per raccogliere i nostri condimenti per la pasta?

da Giorgia | 23 Mag 2020 | Zero Waste
Partiamo dal presupposto che, se non usate la crema solare, la vostra irrefrenabile positività non sarà mai abbastanza per garantirvi il superamento della soglia dei 60 anni. La protezione solare non dovrebbe mai mancare, in nessun caso. Così al mare, così in montagna. Così in cielo, così in terra. Ed anche un po’ in città.
Il compito che affidiamo a queste creme è appunto quello di proteggerci dalle, altrimenti nocive, radiazioni ultraviolette del sole. Tuttavia, molti solari che troviamo normalmente in commercio sono potenzialmente dannosi per l’ambiente marino. Questo dipende dalle formulazioni e dagli ingredienti che troviamo nel tubetto di crema o spray.
Capiamoci meglio, che non fa mai male.
FILTRI CHIMICI VS FILTRI FISICI
I solari lavorano attraverso l’azione di filtri, che possono essere di diversa natura. Quelli più diffusi e largamente commercializzati sono i filtri chimici, che assorbono le radiazioni del sole, scomponendole. “In cambio”, rilasciano energia sotto forma – generalmente – di calore. Li incontriamo nelle creme solari più comuni (o come piace dire a me: “da supermercato”), data la loro iper-spalmabilità e il costo irrisorio della loro produzione.
Questo non vuol dire però che facciano sempre bene, a noi o all’ambiente. Non mi addentrerò nella questione medica: la lascio a chi ne sa ben più di me. Voglio però farvi riflettere sulla questione ecologica.
Molti solari con filtri chimici contengono diversi composti potenzialmente dannosi. Un esempio è l’ossibenzone (Benzophenone-3), un composto organico genotossico per i coralli. Questo mette a rischio la barriera corallina, già parzialmente distrutta, e la sua capacità di resilienza al cambiamento climatico. Inibisce, inoltre, in alcune specie marine la capacità produttiva di uova e quindi la sopravvivenza della specie stessa.
In opposizione ai filtri chimici, la ricerca ha formulato creme contenenti invece filtri fisici. Agiscono sulla pelle in maniera meccanica, un po’ come uno specchio. Questi sono preferibili perché il loro impatto ambientale è nettamente più basso (anche se non è zero).
La verità è che nessuna crema solare attualmente sul mercato è davvero al 100% sostenibile. I filtri fisici spesso sono a base di biossido di titanio e/o di ossido di zinco. Anche questi composti, una volta liberati in acqua, avranno delle conseguenze sull’ecosistema marino. Le nanoparticelle di ossido di zinco e biossido di titanio si ritengono essere più ecocompatibili rispetto all’ossibenzone, ma interferiscono comunque con la fotosintesi delle alghe utili, conducendo allo sbiancamento dei coralli. Il consiglio è quindi quello di NON indossare creme solari di alcun genere quando si visita la barriera corallina. Potrete, solo successivamente, una volta usciti dall’acqua, spalmarvi la protezione. In questo modo, eviterete davvero OGNI impatto negativo sull’ambiente marino.
CREME BIO E SOSTENIBILI: I MIEI CONSIGLI NON RICHIESTI
Ho testato due formulazioni, entrambe con certificazione bio e ipollargeniche. Ci tengo a precisare che per il momento il packaging di entrambi i marchi è ancora in plastica, ma la direzione presa dalle aziende è quella low waste. Tempo al tempo ed arriva anche una confezione plastic free.
- Alga Maris, con protezione 50+ e filtri unicamente fisici: la formulazione è spray, davvero facilissima da stendere. Ingredienti naturali, con certificazione biologica. Perfetta per viso e corpo. Piccola nota: essendo resistente all’acqua, per rimuoverla sarà necessario passare un olio per sciogliere bene il prodotto e tirarlo via. (Qui il link per acquistarla)
- BeOnMe con protezione 50+ e filtri fisici: la formulazione questa volta è in crema, più difficile da stendere, ma è l’ideale per coprire i tatuaggi. L’azienda è italiana – di Trento, se vogliamo mettere i puntini sulle i – e gli ingredienti biologici certificati. Altro big plus: il prodotto è adatto ai vegani. (Qui il link per acquistarla)
Pagina 3 di 6«12345...»Ultima »