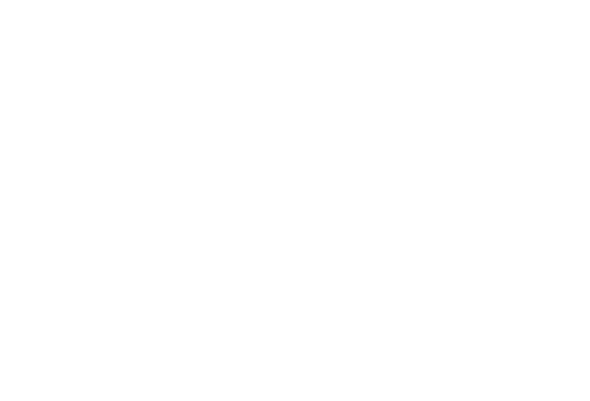da Giorgia | 29 Mar 2020 | Slow Eating
Il Covid-19 non risparmia nessuno; colpisce anche uno dei settori primari, già in forte crisi prima dello scoppio della pandemia: l’agricoltura. In questo periodo, frotte di lavoratori stagionali sarebbero arrivati dall’Europa dell’Est e dal Nord Africa per raccogliere, tagliare e trasformare frutta e verdura dei campi italiani.
Un lavoro sfiancante e molto spesso sottopagato, che prevede anche, in alcuni casi, lo sfruttamento della manodopera straniera, senza l’impiego di alcuna forma contrattuale valida. Tuttavia, stiamo imparando a nostre spese quanto questa categoria di lavoratori sia l’elemento fondante della nostra industria alimentare. Ci sono necessari per non morire tutti di fame.
Gli agricoltori hanno presto lanciato il grido dall’allarme; Coldiretti ci fa sapere che quest’anno mancheranno nei nostri campi 370mila lavoratori regolari provenienti dall’estero. L’intera filiera produttiva è quindi a rischio. Con frontiere chiuse e Schengen-cartastraccia, questa manodopera non può raggiungere i campi italiani o quelli del resto dell’Europa occidentale. La conseguenza fondamentale è che le primizie di questo periodo non possono essere raccolte, ma rimarranno invece a marcire. Chiaramente uno spreco di risorse e di cibo, che va contro tutti i 17 SDG sanciti dalle Nazioni Unite per il 2030.
Se guardiamo poi agli interventi predisposti dal governo italiano, al momento non possiamo che metterci le mani nei capelli e piangere in mandarino. Nel DPCM del 22 marzo 2020, sono state individuate tutte quelle attività che possono continuare a svolgersi, poiché ritenute “essenziali”. Chiaramente, l’agricoltura, l’allevamento e l’apicoltura sono annoverate tra queste. Tutto ok, quindi?
No. Si apre un tiny little problem. Un cavillo burocratico che dà la mazzata finale agli “hobbisti“, ovvero tutti coloro i quali non hanno partita iva, ma svolgono comunque un’attività agricola (occasionale). Questi non potranno continuare a seguire la propria piccola attività, perché il loro codice Ateco – ovvero il codice che classifica le imprese – non risulta in quella lunga lista predisposta dal Governo.
Se hai qualche alveare, ma non hai partita Iva e sei un hobbista, saluta le tue api. Sciameranno via insieme alla speranza di non morire soffocati sotto lo schiacciante peso di questa crisi economica globale.
Non pensate che oltre i confini europei la situazione sia meno allarmante. Anche l’Inghilterra deve fare i conti con l’assenza di manodopera in agricoltura. Mancano all’appello 90mila lavoratori in filiera, provenienti da Ucraina, Moldavia, Lituania, Bulgaria etc. Tutti i paesi non-EU però hanno chiuso i battenti; nessuno esce e nessuno si sposta, dato che anche la maggioranza delle compagnie aeree ha cancellato o ridotto i suoi voli. Diverse associazioni inglesi stanno cercando di convincere il governo della Regina a reclutare forza lavoro straniera, impiegando anche aerei charter che recuperino il personale direttamente in loco.
Il clima è perciò tremendo. Questa crisi anti-globalizzazione richiede un grande ritorno dello stato. Iniziamo a fare più affidamento sullo stato, sul governo, chiedendo a gran voce un suo intervento per tenere in piedi la salute e l’economia. Una spinta non del tutto neoliberale, ma anzi piuttosto sovranista. Ovunque, nel mondo, si osserva una tendenza al rafforzamento della mistica dei confini, una chiusura globale delle frontiere e un’individualismo crescente.
L’esempio lampante è la stessa “Europa delle discordie“. In una situazione diversa da quella pandemica che stiamo attraversando, (forse) l’Unione Europea non avrebbe fatto distinzione di trattamento sanitario ed economico, aiutando con incentivi e interventi efficaci tutti i suoi stati membri. Al momento, invece, la direzione intrapresa è diametralmente opposta. I governi del Vecchio Continente curano tutti il proprio orticello, rendendo Schengen e l’unione un ricordo lontano.
Prima lo “straniero” non era ben accetto; ora invece chiediamo a gran voce che si organizzino operazioni statali di recupero manodopera agricola. Se c’è qualcosa quindi che stiamo imparando da questa pandemia di Sars-CoV-2 è che quei lavoratori che diamo ormai per scontato (agricoltori, allevatori, cassieri del supermercato, autotrasportatori, infermieri, OSS, etc) sono in realtà fondamentali per il funzionamento della nostra società iper-globalizzata.
Chissà, però, se una volta finita, ce ne ricorderemo.
Fonti: agricoltura italiana a rischio, situazione inglese, dati Coldiretti, Stato e pandemia

da Giorgia | 27 Mar 2020 | Informarsi
Questa interminabile quarantena è un po’ come la mano nel film di Verdone: “può esse fero o può esse piuma”. Dipende tutto da come sfruttiamo la quantità di tempo che ora abbiamo a nostra disposizione. Personalmente, non avendo lezioni telematiche, bambini da accudire o lavori da seguire (bello il mondo delle partite IVA in isolamento fiduciario) mi ritrovo tra le mani del tempo, TANTO tempo.
Occhio: non mi sto lamentando. Anzi, tutt’altro. Sono conscia della fortuna che ho: passare l’isolamento al calduccio di casa, con ogni comfort e senza troppe preoccupazioni (first world problems, si intende).
Bando quindi alle ciance. Come sfruttare in maniera formativa
questa quarantena?
Ci dicono che “senza api, il mondo finirebbe nel giro di quattro anni”. Ma perché dipendiamo da un esserino così piccolo e (solo) apparentemente insignificante? Cerchiamo di capirlo. Eccovi una lista di libri per evadere la quarantena, perlomeno con la mente, e comprendere il vitale intreccio tra uomo, natura ed api.
- LA STORIA DELLE API – Maja Lunde
Non fatevi ingannare dal titolo; questo non è un saggio, bensì un romanzo, che oserei definire semi-distopico. Un viaggio tra passato, presente e futuro per comprendere quanto il destino dell’uomo dipenda dalla sua armonia con la Terra.
Maja Lunde, autrice norvegese, immagina un mondo senza api. Corre l’anno 2098. Tao, una giovanissima madre si arrampica sui rami del frutteto vicino casa. Le api non ci sono più: come tutti gli altri impollinatori, si sono estinte. Per poter mangiare, la Cina ha predisposto squadre di giovani donne, tra cui la stessa Tao, per occuparsi dell’impollinazione manuale di alberi e piante. Un lavoro eterno, estremamente stancante, ma necessario per fronteggiare l’insicurezza alimentare. Davvero dobbiamo arrivare fino a questo punto?
2. IL MONDO DELLE API E DEL MIELE – Cinzia Scaffidi
Tutto, ma proprio tutto, sul mondo delle api. Forse io sono di parte, ma trovo questi piccoli insetti davvero straordinari. L’organizzazione sociale dell’alveare, di cui ancora non conosciamo tutto, ed i suoi segreti sono narrati in prima persona in questo testo. Non è scende troppo nello specifico, ma rappresenta un’unione valida di menti sul tema.
Il rispetto della natura passa anche attraverso la comprensione del ruolo fondamentale svolto dalle api, piccole sentinelle e bioindicatori dell’ambiente che ci circonda. Senza di loro non avremmo il miele, certo. Tuttavia, l’impollinazione condotta da questi insetti ci permette cose ben più importanti: mangiare, respirare e vivere.
3. INSEGNANDO S’IMPARA: MANUALE DI APICOLTURA PER EDUCATORI – Giordana Armati
Lo so, dal titolo uno potrebbe dire “ma che è ‘sta roba?”. Vi fermo subito. Questo breve testo è in realtà una gran figata. Me lo sono studiato per tenere un talk “divulgativo” da Eataly, per famiglie e bambini questo Aprile (anche se a questo punto, dubito si terrà mai davvero).
Mi sento di consigliarlo a chi, non potendo dedicarsi ad un corso formativo sul campo, vuole comunque approfondire il mondo assai complesso dell’apicoltura. Com’è morfologicamente struttura un’ape? Per quanto tempo vive? Come si riproduce? Cos’è il miele? Perché insegnare l’apicoltura? E, sopratutto, come proteggere le api?
Semplice, diretto e facilmente comprensibile.
4. L’APICOLTORE DI ALEPPO – Christy Lefteri
Avevo bisogno di piangere in questa quarantena; di riversare su una storia, che non fosse strettamente la mia, tutte le lacrime che avevo in corpo. Questo libro mi è stato consigliato da una ragazza, che non smetterò mai davvero di ringraziare. Era ciò di cui avevo bisogno, ma ancora non lo sapevo.
“L’apicoltore di Aleppo” è stato un caso editoriale del 2019. Un romanzo certamente commovente, dilaniante per certi versi. Ti arriva con tutta la sua dolcezza (tipica del miele) e potenza (tipica delle api). La storia è quella di un viaggio insidioso e lungo, che ha inizio in Siria con lo scoppio della guerra e termina in Inghilterra del Sud, in un quartiere davvero poco residenziale. La tormentata e coraggiosa vita di Nuri, un apicoltore di Aleppo, che si racconta in meno di 300 pagine. Alla fine della lettura ho capito che, nella vita, l’unica cosa a differenziarci e separarci davvero è esclusivamente il privilegio. Siamo solo essere umani che hanno avuto la fortuna di nascere in un luogo dove non ci cadono continuamente bombe sulla testa.
Disclaimer: tutti i testi sono disponibili in formato eBook. Questo vuol dire che non siete stati da me autorizzati a lasciare il vostro domicilio per acquistarne anche uno solo. STATT ACCORT e STATT A CASA.
Photo credits: @hannahhoneycomb – apicoltrice americana che ha tutta la mia stima

da Giorgia | 20 Mar 2020 | Informarsi
Il cambiamento climatico non è un’opinione. Mi spiego
meglio. Non può esistere un contradditorio sull’esistenza di un’emergenza
climatica e della sua natura antropica.
Il cambiamento climatico è un fatto. Esiste, c’è, è qui. Non può essere considerato un’opinione, perché il suo esistere si fonda su dati scientificamente comprovati e condivisi della comunità scientifica internazionale. La sua natura o origine è strettamente legata alle attività antropiche, quelle umane che svolgiamo ogni giorno sul nostro pianeta. Attività che ci spingono ad impiegare sempre più combustibili fossili ed aumentare le emissioni di CO2 o di altri gas serra, in qualsiasi aspetto della nostra vita.
La disinformazione regna sovrana, ce ne stiamo rendendo
sempre più conto. Qui ci sono persone che non solo non sono mosse da alcun
desiderio di conoscenza e voglia di informazione, ma che addirittura non sono
in grado di leggere un grafico o un articolo di giornale (autorevole).
Leggiamo ogni giorno di persone che “non credono nel climate
change”. Peccato che non ci sia nulla in cui credere; basta leggere.
Un po’ come le Foibe o la Shoah. Entrambi fatti concreti del nostro passato, realmente avvenuti, che ci spingono a riflettere sulla crudeltà dell’essere umano. Chi nega, riduce e decontestualizza questi drammatici eventi del Novecento è un negazionista, un folle che bolla come “inaffidabili” questioni ampiamente verificate.
Il cambiamento climatico non è un gatto di Schrödinger in un sistema di regole probabilistiche. Non può contemporaneamente esistere per alcuni di noi e non per altri. Quando 11mila scienziati, ovvero il 99% della comunità scientifica del nostro globo, parla di stato di emergenza, negare è da folli.
Diciamolo una volta per tutte: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO e la sua origine antropica sono un fatto assodato e sostenuto da evidenze scientifiche schiaccianti. I negazionisti del clima – molto spesso invischiati in affari con la stessa industria del fossile – rappresentano una percentuale ridicola rispetto alla massa di scienziati ed organismi scientifici intergovernativi, e non sono MAI (e sottolineo il MAI con una certa enfasi) sostenuti da comprovate evidenze scientifiche.
A conti fatti, poi, le stesse compagnie petrolifere (in particolare 5 delle “7 Sorelle”) da anni foraggiano i gruppi che negano l’esistenza del cambiamento climatico e dell’influenza dell’effetto serra. Il lobbying ad esempio della Exxon Mobil (la nostra italianissima “Esso”) è pressante, in particolar modo negli USA, dove continua a finanziare politici ed opinioni del fronte negazionista.
Abbondonate ogni provincialismo e prendete un libro o report
autorevole in mano. Siamo noi esseri umani ad influenzare in negativo la vita
sul nostro pianeta. Non è un’opinione, ma un fatto.
Fonti: EEA (European Environment Agency) on
Climate Change in 2016
IPCC on Climate
The Guardian on
lobbying

da Giorgia | 18 Mar 2020 | Informarsi
Il Ciad si è accordato con l’Angola per saldare un vecchio debito attraverso un pagamento rateizzato di 75mila capi di bestiame. Esatto, niente soldi o moneta tradizionale, ma bovini per pagare debiti risalenti al 2017. Un occhio poco attento potrebbe percepire la cosa come sinonimo di primitività degli stati africani, che, nonostante l’avanzata della globalizzazione, rifiutano i nuovi sistemi economici, favorendo invece l’arcaico baratto.
La recente notizia ci arriva dalla BBC e può far sorridere se non si conosce la triste piega che stanno prendendo le cose nel continente africano. Parliamo di drammatico calo delle risorse idriche ed insicurezza alimentare, come denuncia la FAO. Una notizia di questo taglio dovrebbe farci comprendere la direzione che prenderanno i futuri conflitti tra Stati. Il nocciolo delle “discussioni armate” tra governi sarà l’approvvigionamento idrico, non più il petrolio.
Ecco perché, per comprendere a fondo la portata di tale scambio economico di bovini, dobbiamo tenere a mente le peculiari condizioni che caratterizzano gli stati africani, sia dal punto di vista antropologico che ambientale, per non trarre conclusioni affrettate, tipiche della mentalità coloniale europea.
Chiediamoci, innanzitutto, perché basare uno scambio
economico tra Paesi su dei capi di bestiame.
I bovini sono al centro delle tradizionali dinamiche socioeconomiche del continente. Sono elemento fondante delle organizzazioni sociali e delle diverse etnie sparse sul vasto territorio africano. Storicamente, i bovini venivano predisposti come dono al momento dei contratti matrimoniali. La concessione, il dare in dote alla famiglia della sposa un certo numero di capi di bestiame sanciva legame matrimoniale e perciò di parentela.
Insomma, la possibilità di pagare il debito in bestiame, anziché in denaro, e la ridistribuzione del “cattle” ad imprenditori e allevatori angolani fungerebbe anche da strumento di regolazione sociale, per il mantenimento della struttura sociale stessa.
Ambiente: perché l’Angola ha rifiutato un compenso
pecuniario, preferendo invece dei bovini?
La Repubblica dell’Angola è tra i paesi africani più ricchi, grazie ai suoi giacimenti petroliferi. Negli ultimi anni, però, ha dovuto fare i conti con gravi problemi di siccità che hanno messo in ginocchio le categorie sociali che basano la loro sussistenza su agricoltura e allevamento. I tassi di mortalità per sete, fame e malattia tra il bestiame sono alle stelle.
Il Ciad, invece, si trova in condizioni economiche ben peggiori; è tra i paesi africani più poveri e dipende in gran parte dall’allevamento di bestiame, la cui esportazione rappresenta il 30% dei guadagni del paese. Guardando i dati delle FAO, notiamo quanto la presenza del bestiame sul territorio sia preponderante: per 1 persona, in Ciad, ci sono 6 bovini.
I problemi di siccità e di sicurezza alimentare, quindi, sono sempre più frequenti, soprattutto nel continente africano. La situazione è particolarmente grave in Ciad, dove il fenomeno della desertificazione avanza di 600 metri ogni anno, mangiandosi terreni coltivabili e mettendo a repentaglio la sussistenza dei singoli agricoltori.
A ciò si aggiunge anche la progressiva perdita di risorse idriche del Lago Ciad, che negli ultimi 50 anni ha perso il 90% della sua portata d’acqua. Inoltre, l’instabilità politica di questa regione subsahariana porta con sé violenza e corruzione, lasciando spazio ad organizzazioni terroristiche jihadiste come Boko Haram. Questa ha assediato le sponde del bacino del Lago Ciad, già indebolito dalla disgregazione ambientale e sociale.
Si inizia a lottare e farsi guerra per accaparrarsi le risorse idriche. Una pericolosa corsa agli armamenti che genera fragilità e spezza l’equilibrio sociale. Una crisi climatica che comporta la drammatica riduzione delle dimensioni del bacino idrico del Ciad e alimenta la fiamma di nuovo conflitti (anche in Nigeria, con le continue rappresaglie di Boko Haram).
Insomma, il cambiamento climatica si fa sempre più sentire
in quelle zone del mondo già indebolite da conflitti sociali e ataviche
tensioni religiose, causando ulteriore morte e distruzione.
“Water wars“
Il pianeta Terra è coperto al 70 dall’acqua, ma soltanto una parte piccolissima, lo 0,5%, è acqua dolce e potenzialmente utilizzabile per alimentazione, agricoltura e allevamento.
Gli Stati, per metterci le mani sopra questa scarseggiante risorsa, combattono economicamente e militarmente tra loro. Ormai da tempo, soprattutto nel corso del Novecento, parliamo di “land grabbing”, ovvero quel fenomeno di appropriazione indebita di terreni agricoli e risorse minerarie. Una corsa olimpionica tra Stati per accaparrarsi diversi beni: oro, terreni coltivabili, uranio, diamanti e soprattutto petrolio. Con l’avanzata della desertificazione, le sempre meno presenti e funzionali precipitazioni e lo stress idrico più in generale, i diversi stati del mondo manifestano sempre più appetiti idrici. Inizia a farsi largo il fenomeno del “water grabbing”, che vede nel XXI secolo non più la lotta per il petrolio, ma per il bene primario per eccellenza: l’acqua. L’ONU ci parla da anni di dati allarmanti relativi a siccità, inquinamento delle falde acquifere, crescita demografica fuori controllo e cambiamenti climatici preoccupanti; tutti fattori che rischiano di rendere l’acqua la causa di un potenziale conflitto su scala globale.
Il rimborso predisposto del Ciad di 75mila capi di bestiame è, perciò, da considerarsi un chiaro esempio della direzione che stanno prendendo i conflitti tra Stati. Al centro del dibattito di questo secolo c’è l’approvvigionamento delle risorse idriche ed alimentari, su cui gravano le conseguenze del cambiamento climatico, In un futuro non troppo lontano lotteremo per garantirci l’accesso ad acqua e cibo.
Fonti: Chad country profile, Angola country profile, Mattanza
sul lago Ciad, Land
Grabbing, Water Grabbing Observatory

da Giorgia | 17 Mar 2020 | Informarsi
Nella nostra vita tutto è fast. Facciamo la spesa con un click, riceviamo i nostri pacchi nel giro di 24 ore, mangiamo sempre di fretta (cibo scadente) nei fast-food, ci muoviamo in macchine super veloci.
Nasciamo, cresciamo, consumiamo. Siamo abituati a consumare, ad acquistare roba su roba, ad una velocità irrefrenabile. Ci muoviamo per il mondo come consumatori, ancor prima che individui. Compriamo tanto, spendiamo poco, ma non siamo mai veramente soddisfatti di ciò che possediamo. Ed ecco che al prossimo periodo di saldi, o alla prima svendita, stiamo già assaltando un qualsiasi negozio, in cerca di un capo che sarà destinato ad avere una vita breve, se non brevissima.
Durerà quanto? Una mezza stagione; forse a malapena. Lo indosseremo due o tre volte, fino a quando non andrà più di moda o non lo troveremo di nostro gusto (anche se, qui, si apre tutto un altro capitolo antropologico) e poi lo butteremo via, perché considereremo nullo il suo valore, come il prezzo che abbiamo pagato per acquistarlo.
Non dimentichiamo però che a questo “walzer dello spreco fast” si deve anche aggiunge la qualità scarsissima dei materiali impiegati e l’impatto ambientale della produzione di quel capo “usa e getta”. Il costo nascosto della produzione dei vestiti “fast-fashion”, della moda veloce, che non guarda alla qualità del prodotto, ma mira esclusivamente alla quantità. Un mondo di contraddizioni evidenti quello in cui viviamo, che vede diffondersi sfruttamento e insostenibilità nella manifattura tessile in paesi come l’India, il Bangladesh, la Cina e la Cambogia. Qui il costo della manodopera gioca a ribasso, rifacendosi sulla pelle dei lavoratori più deboli e poco rappresentati.
Lo scandalo del 2013 del Rana Plaza ha finalmente aperto gli occhi bendati dalla finta convenienza dell’Occidente consumista. Si conta che 1138 persone abbiano perso la vita per il cedimento strutturale del palazzo di nove piani, sede della produzione di abiti per brand Mango, Benetton, Auchan ed altri. Questi disastri, come il numero dei morti, non si contano sulle dite di una mano, purtroppo.
COSA POSSIAMO FARE NOI?
Nel periodo di saldi ci facciamo prendere dalla smania di fare acquisti fini a se stessi, non pensando che spesso questi stessi acquisti non hanno per noi alcuna utilità o beneficio.
Allora chiediamoci: abbiamo davvero bisogno di 14 t-shirt appese nell’armadio? Di acquistare un nuovo paio di scarpe, quando nella scarpiera abbiamo ancora 7 modelli funzionali e funzionanti?
Quando acquistiamo un nuovo capo fast fashion, a bassissimo costo, proviamo una soddisfazione temporanea. Dopo poco tempo ci abituiamo a ciò che abbiamo tra le mani e desideriamo avere altro, qualcosa di nuovo: inseguiamo un’effimera e labile sensazione di benessere dipendente non dall’oggetto acquistato, ma dall’esperienza del consumo. Questa è la logica della società consumistica in cui viviamo.
In questi periodi di saldi vi invito quindi a ragionare prima di fare un qualsiasi acquisto. Di fermarvi a pensare se pagare una maglietta 3€ sia davvero eticamente corretto o se abbiate assolutamente bisogno di quel nuovo pantalone Zara in cotone OGM, cucito da una giovane adolescente in Bangladesh, che ogni giorno rischia la vita.
Nei periodi di saldi, non perdiamo la testa. Agiamo con lucidità e limitiamo gli acquisti inutili e non necessari, ricordando qual è il vero costo sul pianeta ed i suoi abitanti dell’industria del fast fashion.
Per informarvi ed approfondire ulteriormente la questione, vi invito alla visione del documentario “The True Cost”, aprifila del dibattito sul vero costo della manifattura tessile nei paesi non-occidentali. L’analisi mette anche in luce i disastri ambientali causati dall’impiego di sementi OGM e diserbanti by la multinazionale Monsanto. Emotivamente devastante, a mio parere.
Fonte: Rana Plaza, Repubblica
Pagina 5 di 6« Prima«...23456»