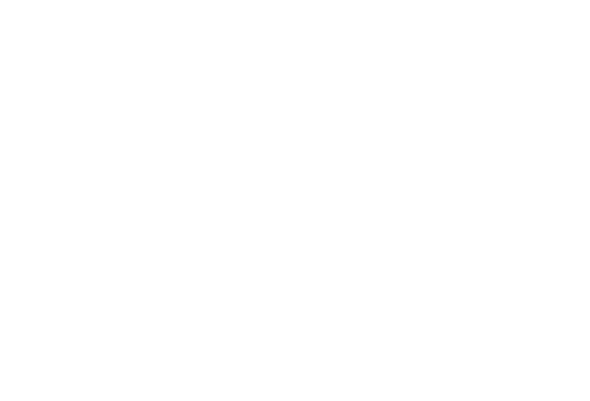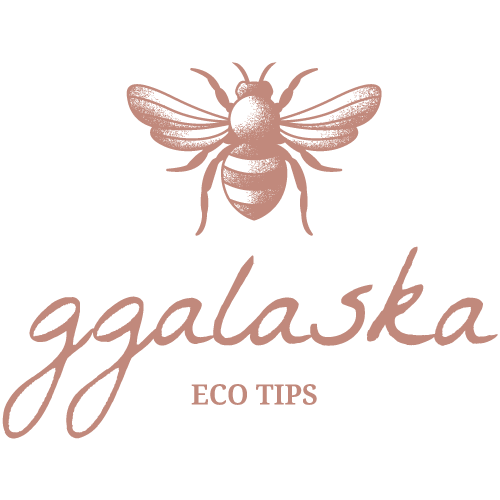
Dispensatrice di consigli non richiesti.

Ultimi articoli del Blog
Zero Waste
Consigli pratici e riflessioni su come vivere più consapevolmente.
La moda Genuina, Innovativa e Naturale: CasaGIN
Cosa significa fare moda etica e sostenibile? Quali sono i rischi d'impresa? Come nasce un'idea? Sono tutte domande che ho rivolto a chi si impegna ormai da anni per una produzione tessile italiana...
Comprare scarpe sostenibili non è più un’utopia
La scarpe sono un tipico prodotto dell'industria della moda fast e consumista. La verità è che siamo stati abituati male: compriamo un paio di scarpe da ginnastica ad ogni inizio stagione, facendoci...
Informarsi
Libri, film, articoli e molto altro per iniziare a muoversi verso un ridotto impatto ambientale.
Perchè adottare un alveare non salverà le api
Quella tra impollinatori, gli uomini e le piante è una danza straordinaria. Un gioco in cui vincono tutti i partecipanti. Gli insetti, tra cui anche le api mellifere, si nutrono di nettare e polline, favorendo la fecondazione dei fiori. Insieme a uccelli particolari,...
La parità di genere e il clima che cambia: ecofemminismo e moda sostenibile
Come sono collegati femminismo intersezionale, lotta ai cambiamenti climatici e moda sostenibile? Il filo rosso che unisce questi macro aspetti in realtà non è così sottile come crediamo. Anzi, è piuttosto evidente quanto ad intervenire sulle disuguaglianze di genere...
Slow Eating
Come la nostra dieta e scelte alimentari influenzano il nostro pianeta.
Quando la dieta Occidentale deforesta l’Asia: il caso gamberetti
Fino a un secolo fa, c'erano 4,2 milioni di ettari di foreste di mangrovie lungo le coste dell'Indonesia. Un numero che adesso ci pare assurdo perchè negli ultimi 25 anni, questi ettari si sono ridotti del 50% (anche fino al 70%, in modo particolare sull'isola di...
Hummus, tra guerra e cucina
Lo mangiamo in tanti e lo cuciniamo in molti. Dovrebbe essere un cibo dall’esecuzione semplice, una ricetta non troppo complicata, eppure l’hummus nasconde una certa difficoltà. Facciamo ancora fatica a delineare la sua provenienza o a comprendere la sua storia. In...